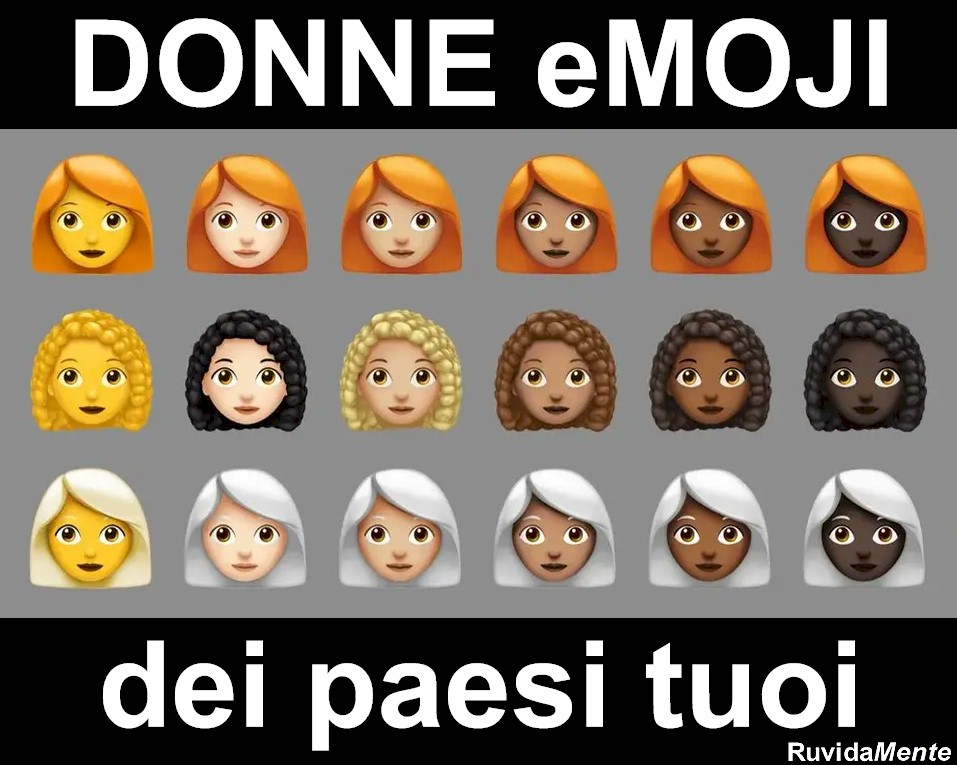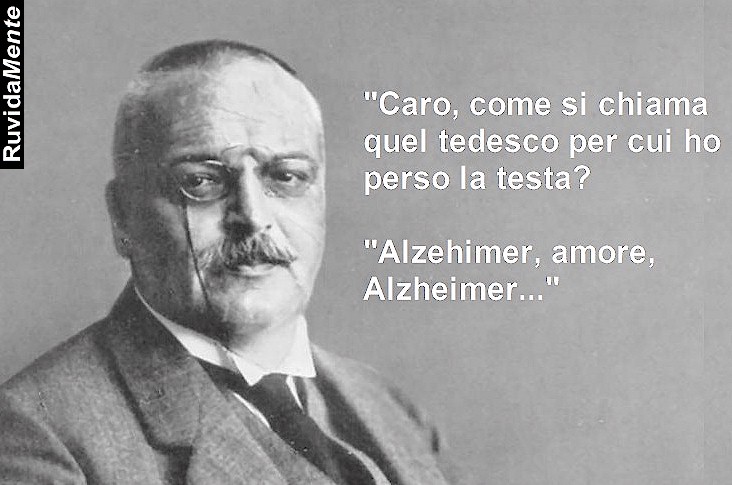Ci si sforza spesso di trovare similitudini tra il mondo del vino e quello della birra. Superati i più banali parallelismi, si finisce per forzare la realtà al fine di trovare identità ideali che, di fatto, oltre una certa soglia non esistono. Ciò è dovuto ad un fattore sostanziale, che trascende gli aspetti tecnici e gustativi a monte e a valle dei due prodotti: il vino nasce come elaborazione di una materia prima, l'uva, che in altro modo non potrebbe essere conservata e, qualora non consumata in tempi brevi, andrebbe perduta. Al contrario, la birra nasce dall'elaborazione di una materia prima, i cereali, che possono essere conservati ed utilizzati con sufficiente tranquillità, senza la necessità di applicare tecniche create ad hoc.

In sostanza, il vino si fa quando lo decide la natura, la birra quando lo decide l'uomo.
Proprio da questa stretta connessione con gli eventi naturali, soggetti, in tutte le civiltà primitive, al volere della divinità, dipende il fatto che al vino si attribuisca una forte componente rituale, pressoché assente nella birra. Ecco quindi che il vino diventa protagonista nei momenti a forte valenza simbolica, sia in ambito religioso che laico, dall'eucarestia al varo di una nave, dalla celebrazione di un matrimonio (il primo miracolo di Gesù) ai festeggiamenti per una vittoria sportiva.
Questa componente rituale ha fatto sì che, in qualunque epoca, di vino ne esistessero due categorie: quello corrente, per tutti i giorni, buono per nutrirsi, acquisire energie fisiche e psichiche, ed anche ubriacarsi, e quello per i momenti importanti, messo in tavola per celebrare, suggellare, gratificare, onorare. Da sempre, la qualità è stata prerogativa della seconda tipologia, e questo ha dato luogo allo svilupparsi di due distinti mercati che hanno finito per convergere solo negli ultimi decenni, quando anche i vini della prima tipologia hanno cominciato ad essere distribuiti in bottiglia, condividendo con i secondi (e spesso contendendo ai secondi) gli scaffali dello stesso punto vendita.

Questa promiscuità commerciale ha prodotto effetti tanto negativi che positivi, ma nel saldo finale chi ci ha rimesso è il rito e chi ci ha guadagnato, forse, è il consumatore.
Il rito ci ha rimesso perché il vasto pubblico dei consumatori "normali", quelli non enologicamente acculturati, ha trovato conveniente mettere in tavola, in occasione di feste, ricorrenze ed eventi familiari, bottiglie di basso costo ma fornite di tutti i crismi esteriori della qualità, ovvero un tappo, una capsula, una bella etichetta, un nome accattivante e, perché no, la rassicurante sigla "DOC".
Il consumatore - quello attento ed intelligente, almeno - ci ha guadagnato perché le bottiglie di qualità hanno potuto schiodarsi dal secolare circuito vizioso di Natale, Capodanno, Pasqua e ricorrenze varie, ed esser servite in tavola anche se, da celebrare, non c'era null'altro che il proprio personale desiderio di provare piacere.

Nelle pieghe di questa confusione di ruoli e relativa trasmigrazione di presenze, si sono radicalizzate tipologie di prodotti vinicoli più o meno manifestamente finalizzati alle occasioni rituali.
Il posto d'onore, ovviamente, spetta alla famiglia dei vini spumanti che, in poco più di un secolo, si sono trasformati a tal punto nel simbolo della celebrazione gioiosa e conviviale che il loro consumo si concentra quasi totalmente nel periodo che va dal 24 Dicembre al 6 Gennaio. La forza del rito è stata così forte che ha spinto moltissimi produttori ad avventurarsi in una produzione ad hoc, anche laddove non esisteva alcuna tradizione di bollicine. E di fianco ai vini da festeggiamenti per eccellenza, l'Asti Spumante e lo Champagne, sono cominciate a sorgere produzioni più o meno di fantasia, declinate nelle tipologie del dolce e del secco, che hanno trovato sempre buoni sbocchi di mercato, seppur concentrati nelle ultime settimane dell'anno.
Per vie diverse, anche un'altra categoria di vini ha rischiato di soffrire per aver approfittato per anni dei riflessi del rito: i grandi vini rossi. Non quelli celebrati dalle guide, ma quelli che godono di una generalizzata reputazione di "grandi vini", come il Brunello, l'Amarone, il Barolo e il Barbaresco.

Per anni (ed ancora oggi) una consistente fetta delle loro vendite è stata veicolata dalle confezioni regalo (cassette, cesti, confezioni astucciate). Questo, ovviamente, ha una sua logica: chi fa un regalo vuole che sia immediatamente riconosciuto come regalo di valore, qualunque sia la cultura enologica del ricevente, e con questi mostri sacri sa che non sbaglia mai. Il rovescio della medaglia è che, per decenni, i migliori vini del nostro paese sono stati comprati da chi non li avrebbe mai bevuti, e bevuti da chi non si sarebbe mai sognato di comprarli. E quando chi paga si cura di più dei fattori esteriori che di quelli sostanziali (l'immagine al posto della qualità) i riflessi a monte non possono essere che negativi.
Questo è vero, sempre. Ma, una volta tanto dobbiamo levarci tanto di cappello e riconoscere che, negli ultimi anni, i nostri produttori di vini in cui la qualità percepita è indipendente dal loro valore oggettivo hanno avuto la forza (ed anche la lungimiranza) di non farsi abbagliare dalle festose luminarie natalizie ed hanno perseverato nel loro percorso di rinnovamento nel segno della qualità, dandoci l'eccellenza indipendentemente dal fatto che la destinazione fosse la cantina di un tre stelle Michelin oppure un bel cesto da regalare al capufficio.
VAI A
 RuvidaMente
RuvidaMente