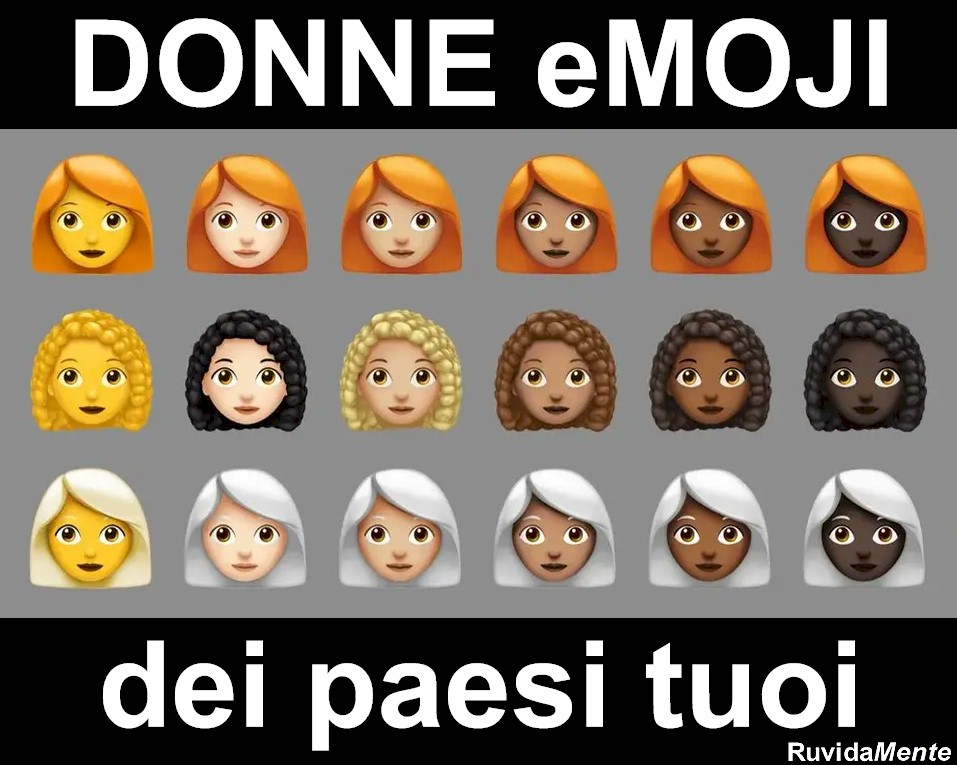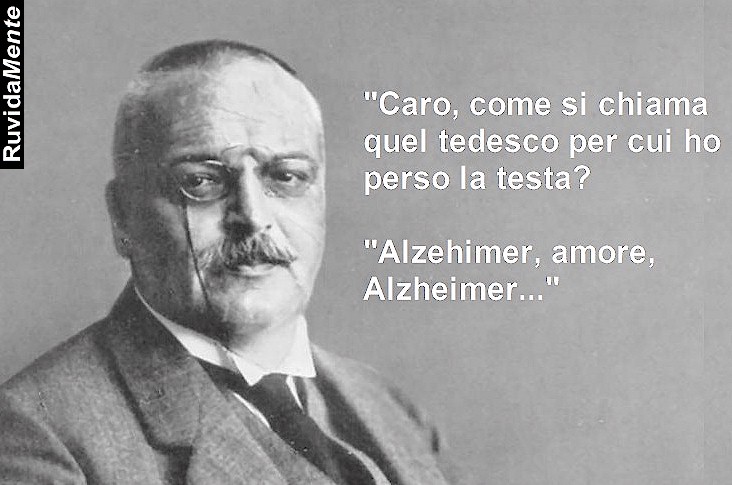Uno dei protagonisti occulti dell'Antico Testamento é il vino. Ma la sua presenza frequente non é marcata sempre dallo stesso registro: scorrendo le pagine con l'occhio rivolto ai tanti episodi in cui sono coinvolti il vino, la vite e la vigna, ci si rende conto come presso l'antico popolo ebraico questi elementi, oggi a noi così familiari, fossero considerati alternativamente come simbolo del male, oppure del bene.
Approfondendo la ricerca, si scopre che questo atteggiamento, drastico tanto nella positività come nella negatività, non é dettato da motivazioni razionali ma da convenienza squisitamente politica.
Il vino é "demonio" quando il popolo ebraico é in guerra, quando é alla ricerca di una nuova terra, quando soffre della tirrania di un altro popolo e non vede innanzi a se' altra strada all'infuori di quella dell'emigrazione e della fuga.
Il vino é elemento buono e santificante quando la nazione é in pace, la terra su cui si vive é stata acquisita stabilmente, gli sforzi di ognuno sono diretti alla costruzione di piccole e grandi opere di civilizzazione.

Decidere di impiantare un vigneto, allora forse più di oggi, voleva dire vivere nella certezza della proprietà, sapere di poter investire con tranquillità i lunghi anni necessari prima di poter godere del primo raccolto, poter contare su un ambito sociale favorevole ed amico, capace del più disinteressato aiuto nel momento delle difficoltà.
Non é casuale che la storia del vino sia parallela ed integrante a quella delle grandi civiltà e che il suo sbocciare goda dello scenario incomparabile, allora come oggi, delle terre che si bagnano nel Mediterraneo.
Dobbiamo alla civiltà greca le prime grandi espressioni di tecnica enologica, i primi vini così costanti nella loro qualità da poter diventare, di diritto, protagonisti di opere immortali, nella poesia, nella pittura, nella scultura.
E dobbiamo ai Greci lo sbarco sulle nostre coste meridionali di una pratica colturale evoluta che ha permesso ai vini della Magna Grecia di diventare famosi ed apprezzati al pari delle opere architettoniche, intellettuali e sociali che venivano realizzate a Siracusa, Agrigento, Pestum, Selinunte, Sibari, Metaponto.
I Greci portarono in Italia dapprima i vini, imbastendo lucrosi commerci, quindi i vitigni che avevano selezionato diligentemente durante secoli di pratica agricola, infine le tecniche di coltivazione e vinificazione, un patrimonio inestimabile su cui si basarono, con pressoché immutata applicazione, gran parte delle fortune dell'universo vinicolo romano.
L'avvio non fu dirompente, e se le qualità del buon vino erano apprezzate tanto nel vociare delle taverne come nell'armonia dei versi più raffinati, per secoli la legge cercò di limitarne il consumo, bandendolo ai giovani fino all'età di 21 anni, costringendo lo stesso Romolo ad utilizzare il latte come bevanda sacrificale, inducendo Numa a vietarne l'aspersione sul rogo, sottoponendo a pene durissime le donne che vi si fossero accostate.
Erano le limitazioni di uno stato che stava lentamente costruendo la propria civiltà e, con essa, la propria enologia.

Pestum

Agrigento

Siracusa

I vini arrivavano, comunque, a Roma, prima di tutto dalla Magna Grecia, e buon mercato godevano il Mamertino, che ancora oggi si produce (in attesa di Doc) in provincia di Messina, ricco di sole e gradazione alcolica, comparabile, con un salto di oltre venti secoli, al più asciutto dei White Port; oppure il Pollio, anch'esso tuttora vitale in provincia di Siracusa, dolce e liquoroso da uve moscato leggermente appassite, ed il Tauromenitanum, dalle coste collinari di Taormina, oggi perduto.
Il vino più celebrato, comunque, veniva prodotto pressoché alle porte di casa, a Mondragone e dintorni, ed il suo nome, Falernum, evoca ancor oggi le immagini più belle che si possano associare ad un vino. Cantato da tutti i più grandi poeti della latinità, vanta citazioni illustri a firma Catullo, Marziale, Plinio e poi, cammina cammina, addirittura Torquato Tasso e Carducci.
Tanto esperti ed esigenti erano i Romani che distinguevano, nell'ambito della produzione di questo vino, le zone migliori (i "cru"), preferendo quello proveniente dai vigneti delle più basse pendici, e distinguendo, inoltre, tra il Gaurano, prodotto sulle pendici del Monte Gauro, ed il Faustiano.
Al Falerno si associavano il Cecubo, dal colore rubino acceso ed ancora oggi prodotto tra Fondi, Sperlonga e Gaeta, il Velletrano, assimilabile al contemporaneo Velletri ed il Setino di Sezze. Da terre più lontane (per quei tempi) il Peligno ed il Petruziano, antenati degli attuali Montepulciano e Cerasuolo d'Abruzzo, e, dal Veneto, i padri storici del Prosecco, il Preciano ed il Reatico.
I commerci di vino, a Roma, si fecero di decennio in decennio così intensi che lo Stato si sentì in dovere di regolamentarli in maniera molto dettagliata e di dedicare loro addirittura un intero mercato specializzato, gli Horrea Galbae, il più grande di tutti i mercati della città, esteso su un'area di circa tre ettari. E di raggruppare tutti coloro che erano coinvolti nel commercio dei vini in una corporazione, il Corpus Vinariorum, considerata tra le sei più potenti della città.

Se per qualche secolo la punta di diamante dei commerci vinicoli fu costituita dai vini greci, soprattutto quelli provenienti dalle isole di Rodi, Cipro, Lesbo e Chio, insidiati, con l'andar del tempo, da quelli provenienti dalla Spagna, dall'Asia Minore e dai paesi mediterranei dell'Africa settentrionale, pian piano cominciarono ad affacciarsi sul mercato romano anche i nuovi vini italiani, figli di quelle avanguardie che fin dal quinto secolo a.C. fecero dire a Sofocle che l'Italia era il paese prediletto da Bacco, ed indussero scrittori e storici a battezzarla Enotria, paese del vino e dei vigneti.
Cercare un filo conduttore razionale alla scoperta dei vini italiani dall'Impero Romano ai giorni nostri sarebbe impresa sterile e noiosa. Meglio affidarsi alla lieve e gioiosa guida del verso poetico e della pagina letteraria, illuminante se quel che cerchiamo é la testimonianza della indomabile concentrazione di vitalità che si racchiude in un bicchiere di vino.
I POETI
Così, non può essere casuale che Virgilio, Plinio, Orazio, Strabone ed Augusto si siano dilungati a tessere le lodi dei "Retici vini", provenienti da quella "Rezia" che oggi identifichiamo principalmente con la Valtellina, terra tutt'oggi aspra e faticosa da coltivare, ed ancora degna delle lodi dei poeti, in rima e non, dei nostri giorni.
Da un'altra terra al confine Nord della penisola, la Val d'Aosta, la testimonianza di un vino che, grazie alla sua qualità, riuscì a farsi apprezzare ai banchetti imperiali, il Vien de Nus, rosso rubino che pare abbia accecato, con i suoi sapori, Ponzio Pilato di passaggio in queste zone, al punto da farne un suo promotore accanito nella migliore società romana.

I CAVALIERI
Incredibilmente, il vino riesce ad allineare, comprimari della stessa commedia, poeti ed uomini politici, storici e condottieri gloriosi. Spesso é loro compagno di trionfi, talvolta complice segreto ed insidioso come nel caso del Bianco dei Campi Raudi, un vino dorato prodotto tuttora in provincia di Novara, che nel 101 a.C. divenne sorprendente alleato di Caio Mario, avendo spinto, con la sua soavità, alle mollezze del vivere stanziale le tribù dei Cimbri.
Proprio nella Piana dei Campi Raudi si svolse la cruenta battaglia che riuscì a fermare la prima invasione barbarica della penisola: 120 mila tra morti e feriti, 60 mila prigionieri, gli storici a disquisire sul valore dei legionari romani, la tradizione popolare che identifica l'episodio storico nel nome del vino, unico sopravvissuto alla battaglia, ancora due millenni dopo.
Se un vino aiutò i Romani a sconfiggere il primo barbaro invasore, un altro, ahimé! donò al nemico forza e vigoria per aver ragione delle legioni e riuscire a mettere a sacco addirittura Roma.
Siamo nel 410 d.C. ed Alarico, re dei Visigoti, scende dal Veneto con le sue orde. Attraversando il territorio marchigiano si imbatte nei vini prodotti nei dintorni di Cupramontana e "nulla a se' stimando recar sanitade et bellico vigore melio del Verdicchio" decide di prelevarne la bellezza di 40 some.
Quel che accadde a Roma all'arrivo di Alarico é noto a tutti, anche se il merito (o la colpa) non fu certo del Verdicchio, più adatto, per la sua soavità, ad accompagnare pensieri di pace, di gioia, e, magari, di battaglie amorose.
Eppure, la favola del vino apportatore di energie guerresche si propone ricorrente in ogni epoca della storia ed avvolge nel mito anche il più antico dei vini italiani, quel Greco di Bianco prodotto in pochi e ben definiti vigneti del comune di Bianco (definiti da oltre duemila anni, al di là di qualunque intervento della legge), in provincia di Reggio Calabria. Qui la Storia vuole che nel 560 avanti Cristo 10.000 Locresi, rincuorati e rinvigoriti da abbondanti libagioni di Greco, siano riusciti a sconfiggere l'esercito di Crotone, composto di ben 130.000 uomini. Nelle sequenze della cruenta battaglia, quasi a stemperare i troppi meriti attribuiti a quel vino, il mito spinge nella mischia, al fianco dei Locresi, addirittura Castore e Polluce, inviati in loro soccorso appositamente da Apollo, ma noi, da abitanti razionali del XXI secolo abbiamo il dovere di rilevare che quell'efficace Greco di Bianco, denso, dolce e ricco di mille sapori e profumi, oggi é ancora lì per tutti quelli che lo sanno apprezzare, mentre dei Dioscuri si sono perse, da un pezzo, le tracce.
Se le guerre riempiono la storia, talvolta le storie scatenano aspre battaglie. E' il caso della Naturalis Historia di Plinio, che qua e là é riuscito a farsi ricordare anche per le polemiche scatenate tra i posteri più remoti. In un passo cita il Pucinum, vino dell'alto Adriatico che alcuni identificano oggi nel Prosecco di Trieste, aspramente contrastati da coloro che lo vogliono padre del Refosco.
Quale dei due fosse (ma l'aver definito la vite del Pucinum "omnium nigerrima" fa propendere per la seconda ipotesi), le cronache lo tramandano come il vino preferito da Livia, sua moglie, ghiotta ed avveduta intenditrice che, abile nell'amministrare le sue voglie gastronomiche, riuscì a campare fino all'età di 86 anni, un vero primato per quei tempi.
LE DONNE
Con Livia abbiamo consumato il nostro primo incontro con una donna vera nel mondo del vino. Prima era solo un gran svolazzare di vestali, di ancelle, di sacerdotesse, di comparse piacevoli alla vista ed inutili al contesto, salvo il suggerimento di trasferirsi, complice l'ebbrezza, alla pratica di tutt'altro genere di piaceri.
A quello di Livia faremo seguire il ricordo di Galla Placida, imperatrice bizantina che estasiata da una tazza di Albana esclamò "Sei troppo buono o vino dorato per esser bevuto in rustica coppa. Vorrei berti in oro!", e l'esclamazione fu sufficiente a far battezzare il paese teatro dell'episodio "Bertinoro", ancor oggi capitale incontrastata dell'Albana di Romagna.
E' una leggenda fragile, facilmente contestabile (che lingua si parlava, nel V secolo dopo Cristo, alla corte bizantina?), ma che testimonia della vocazione di questo vino degno, fin dai suoi primordi, della mensa imperiale e, più tardi, di quella, sempre imperiale ma decisamente meno raffinata, di Federico Barbarossa, ghiotto al punto da ubriacarcisi quotidianamente.

Le sabbie mobili della classicità potrebbero trattenerci per pagine e pagine a disquisire di vini e citazioni repubblicane, imperiali e tardo imperiali, ma prima di operare il deciso balzo in avanti che ci permetterà di allargare il ventaglio del nostro saltabeccare ai cento vini che alterniamo ogni giorno sulle nostre tavole, é d'obbligo la citazione quasi retorica del Cirò, anticamente "Cremissa", vino calabro caldo e generoso, oggi più che mai bandiera indiscussa dei vini meridionali di qualità.
Tale e tanta era la sua considerazione che ne veniva fatto dono agli atleti che tornavano vittoriosi dalle Olimpiadi, e a dispetto dei tanti grandi vini, italiani, francesi e tedeschi, pervenuti a fama indiscussa nel trascorrere dei secoli, ancora durante le Olimpiadi di Città del Messico del 1968 ebbe l'onore di occupare, in esclusiva, le tavole delle mense degli atleti, quasi a sancire un ideale continuità tra il valore dell'ideale olimpico di allora e di oggi.
Due terre, oggi vinicole per eccellenza, appaiono defilate nello scorrere di questo parallelismo tra la crescita civile, sociale, artistica ed enologica dei nostri antenati: la Toscana ed il Piemonte.
E' vero, Cesare di ritorno dalla Gallia non mancò di lodare gli ottimi vini de La Morra, oggi capitale del Barolo, ma per trovare tracce più concrete e vitali bisogna adattarsi a far balzi di quasi mille anni.
Una comoda leggenda cerca di accreditare al secondo secolo a.C. le prime tracce del Barbaresco, il Barbaritium che servì a Caio Arrunte, ricco mercante di Chiusi, per convincere i Galli ad un'alleanza che gli permise di vendicare sull'intera città i suoi dolori di marito tradito.
Più credibilmente, però, possiamo far nostra la vicenda di un manipolo di Saraceni (detti anche Barbareschi) che intorno al 900 d.C. invasero Alba ma, traditi dalla bontà del vino che vi trovarono copioso, caddero tutti prigionieri.
Sono anni, quelli a cavallo del Mille, in cui la produzione vinicola piemontese, ben sviluppata ed apprezzata ormai da secoli, inizia a dotarsi di una identità precisa, degna di definizioni più pregnanti della solita sequela di aggettivi laudatori, propri del fraseggiare di storici e cronisti.
Editti, bolle e testi di legge cominciano ad occuparsi della produzione vinicola, la inquadrano in un contesto normativo, salvaguardano produttori e consumatori.
Ma dobbiamo arrivare al 1537 per veder citato ufficialmente il Barolo in un banchetto tenuto ad Alba in onore di Carlo V.
Sul fronte toscano, la palma dei primi riconoscimenti ufficiali spetta alla Vernaccia di San Gimignano che già alla fine del '200 era protagonista di fiorenti commerci e le sue esportazioni venivano controllate da funzionari comunali appositamente assunti per questa mansione.
La cita Dante nella Divina Commedia; il Boccaccio inventa un "fiumicel di Vernaccia" nel fantastico panorama del paese di Bengodi e Santa Caterina da Siena trova modo di descriverne l'azione miracolosa per la salute di infermi e debilitati.
Poi, di secolo in secolo, é un continuo salire agli onori delle cronache, dalle citazioni di Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo II, fino alle mense di Lorenzo il Magnifico, di papa Leone X e di Ludovico il Moro che ne volle 200 fiaschi per allietare le nozze del nipote Gian Galeazzo con la figlia di Alfonso II, re di Napoli. Per chiudere con l'onore di vedersi riconosciuta, il 6 maggio 1966, prima in Italia, la Denominazione di Origine Controllata.
Con un secolo di ritardo, rispetto alla Vernaccia, troviamo tracce del Chianti in documenti dove la parola indica per la prima volta il vino che tutti apprezziamo e non l'area geografica da cui proviene: covava, é evidente, il suo splendore da qualche secolo, ma solo in quegli anni esplose nella sua incontrastata supremazia, oggetto di regolamentazioni ferree, tese a salvaguardare la qualità, il prezzo, la provenienza da comuni e vigneti minuziosamente catalogati.
Da allora in poi furon successi folgoranti, la penetrazione su tutti i mercati europei, l'entusiasmo dei regnanti delle corti di Parigi e di Londra, l'arricchimento dei mercanti di fiaschi impagliati, seducenti già allo sguardo, prima ancora di assaggiarne il contenuto.
Se la Vernaccia di San Gimignano gode del primato di essere stata la prima Doc italiana, l'Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, giunto a questo riconoscimento con un solo giorno di ritardo (il 7 maggio 1966), si rifà sulla prima grazie al fascino delle sua illustre e certa data di nascita: l'anno 1110. Fino ad allora il vino prodotto sulle pendici che salgono dalle rive del lago di Bolsena fino all'abitato di Montefiascone erano apprezzati in ambito locale, lodati dai viandanti, presenti nei grandi centri più nel ricordo e nei racconti che per effettiva esistenza di commerci.
I GUERRIERI
Ma quell'anno accadde che l'imperatore Enrico V si spostasse verso Roma alla testa di un potente esercito, per chiarire alcune controversie con Papa Pasquale II.
Al seguito di questa spedizione si trovava anche un vescovo, Mons. Giovanni Defuk che, deciso a godere più dei vantaggi turistici e dionisiaci della spedizione, che di quelli politici, si faceva precedere, in ogni borgo, dal suo coppiere Martino con il compito di selezionare i vini delle migliori cantine.
Giunto a Montefiascone, Martino non trovò sufficiente scrivere "Est!" vicino alla porta dell'osteria per indicare la presenza di buon vino. Il segnale convenuto non faceva giustizia della bontà di quanto vi aveva degustato e, non avendo concordato altrimenti, pensò di ripetere tre volte quell'"Est!", rafforzandone l'importanza e la perentorietà. Nacque quel giorno la fama e la gloria dell'Est!Est!!Est!!!, dal momento in cui Defuk assaggiò il vino e, rapito dalla sua soavità, prolungò la sosta per ben tre giorni, tornandovi poi al termine della missione imperiale e restandoci fino alla morte, coronata dalla sepoltura nel locale tempio di San Flaviano e dall'usanza, perpetuata per qualche secolo, di rovesciare ogni anno un barile di vino sulla sua lastra sepolcrale.

Quelli di questa terra dovevano certo essere vini capaci di scatenare grandi entusiasmi se personaggi di chiara fama e grandi responsabilità se ne innamoravano in maniera così irrazionale.
Basta spostarsi di pochi chilometri, da Montefiascone a Orvieto, per trovare altre testimonianze di folli passioni.
Il Pinturicchio, chiamato nel 1492 ad affrescare la Cattedrale, assaggiato il vino delle osterie locali, pretese di inserire nel suo contratto la clausola "che gli si desse di quel vino orvietano tanto quanto ne volesse".
Ma se il pittore poteva essere uno scavezzacollo, che dire di Papa Gregorio XVI che nel suo testamento dispose di lavare il suo corpo con vino di Orvieto prima della sepoltura?
Il buon vino, comunque, ha sempre spinto le intelligenze più fervide almeno alle piccole trasgressioni, a valutare situazioni, patteggiamenti e convenienze con un metro diverso da quello scandito dalla fredda moneta corrente. E' il caso dei Marchesi di Saluzzo che nel 1369 sollevarono da tasse ed obblighi militari gli abitanti di Dogliani, a patto che fosse pagata un'imposta annuale in natura, misurata, ovviamente, a barili di buon Dolcetto. Oppure, trent'anni dopo, del vescovo di Torino, Aimone di Romagnano, che, anziché denaro, pretese botti di Nebbiolo in pagamento dell'affitto dei terreni di proprietà della diocesi.
Ogni volta che ci imbattiamo in simili episodi, di un fatto possiamo esser certi: che il vino usurpatore del ruolo della moneta vantava una superiorità qualitativa abissale nei confronti di quelli prodotti nelle zone limitrofe. Solo grazie a questo salto di qualità riusciva ad entrare nel cuore e nelle aspettative dell'uomo potente ed indurlo a conferirgli un valore superiore a quello di qualunque somma in denaro.
E la storia dei vini italiani é un susseguirsi continuo di intrecci fecondi tra abilità contadina, esaltazione letteraria e salvaguardia legislativa. I vini finora citati hanno goduto di un lampo vitale che li ha fatti uscire dal mucchio e li ha imposti, ammantati di un fascino nuovo, agli occhi di tutti.

Ma non c'è vino di qualità che nel suo passato, almeno una volta, non sia stato citato, foss'anche da un letterato di fama dimessa, come vino degno delle mense dei "signori", oppure dei "nobili", o dei "potenti".
In secoli più recenti, la gloria di un vino é legata maggiormente alle risposte del mercato ed il verso del poeta assume il ruolo di un suggello autorevole alla qualità già accreditatasi per vie mercantili.
E' il caso del Marsala, cui poco giovò l'innamoramento di Rubens, sceso in Italia per studiare l'arte di Tiziano e Caravaggio, e tornato in patria con gli occhi pieni della nostra arte ed il bagaglio appesantito da una abbondante scorta di vino siciliano.
Deve trascorrere più di un secolo e devono scendere in Sicilia due uomini d'affari inglesi, John e William Woodhouse, per far esplodere la fama del Marsala in tutta Europa.
ANCORA POETI
Poi Garibaldi brinderà con quel vino al successo della spedizione dei Mille, alzando i calici insieme ad Alessandro Dumas, che ne resterà rapito, ma il successo, irreversibile, é già stabilmente siglato dalla indiscussa qualità del vino e dalla strada tracciata dai mercanti inglesi.
Così come, nelle Cinqueterre, non c'è verso o citazione letteraria che possa esprimere l'emozione profonda che dona la vista di quelle vigne inerpicate ai limiti del praticabile per coste scoscese che, in pochi metri, si trasformano da scogliera in montagna, evocando il concetto di collina solo per assenza recidiva.
Boccaccio e Petrarca gli dedicarono versi e citazioni, Plinio lo definì "vino lunare", Carducci lo descrisse come l'essenza di "tutte le ebbrezze dionisiache", Pascoli ne invocò l'invio di poche bottiglie "in nome della letteratura italiana", D'Annunzio, maestro consumato di piaceri terreni, ne ostentò la profonda sensualità.


Eppure, le vie del mondo non sono di questo vino, nessuna parola ben declamata é buona per imporlo sui mercati forestieri: bisogna salire le dure coste dei vigneti, sudare sotto il sole che abbaglia moltiplicato dai riflessi marini, scrutare una ad una le rughe profonde dei vignaiuoli perennemente appesi tra cielo e mare. Solo così ci invade una voglia irrefrenabile di berlo, uguale, oggi, a cento e mille anni fa.
UN MITO GIOVANE CENT'ANNI
In una terra così ricca di storia, e di storia enologica, può succedere anche che il divo del momento possa insinuare le sue radici ovunque, tranne che nel comodo giardino della tradizione, del passato, della millenaria esperienza.

Francesco Redi, nel suo Bacco in Toscana, cantò le glorie di tanti vini illustri, incluso il fascinoso Moscadelletto di Montalcino, dolce, biondo e spumeggiante.
Ed ecco che, nello stesso luogo, quasi alle soglie del Novecento, frutto della straordinaria sinergia tra meandri mentali e capacità di "fare" di un solo uomo, Ferruccio Biondi Santi, nasce, per contrappasso, un vino rosso, corposo, di straordinaria energia, capace di migliorarsi al di là delle soglie temporali che creano, negli altri, le condizioni della vecchiaia e dell'inevitabile decadimento.
Il Brunello di Montalcino nasce nella terra che sembra dovere tutto alla natura, alla spontaneità, alla benevolenza del clima, alle consumate tradizioni enologiche dei vignaiuoli. Nasce come trasgressione, come paradosso, come "dispetto" alla retorica di una terra che "sa", da quasi tremila anni, come si fa e come si deve fare il vino. E' la sfida del futuro in una terra costruita di passato.
Ed é una sfida vinta in tempi folgoranti: é bastato meno di un secolo per creare il mito del Brunello in tutto il mondo, senza le testimonianze degli storici, i versi degli immortali, le smodatezze dei potenti.

Solo questo é sufficiente a dare grande sicurezza ai viticultori italiani di oggi: la forza di un passato inimitabile alle spalle e la coscienza di poter avanzare verso il futuro senza che questo bagaglio di esperienze possa trasformarsi in un pesante fardello.
 RuvidaMente
RuvidaMente