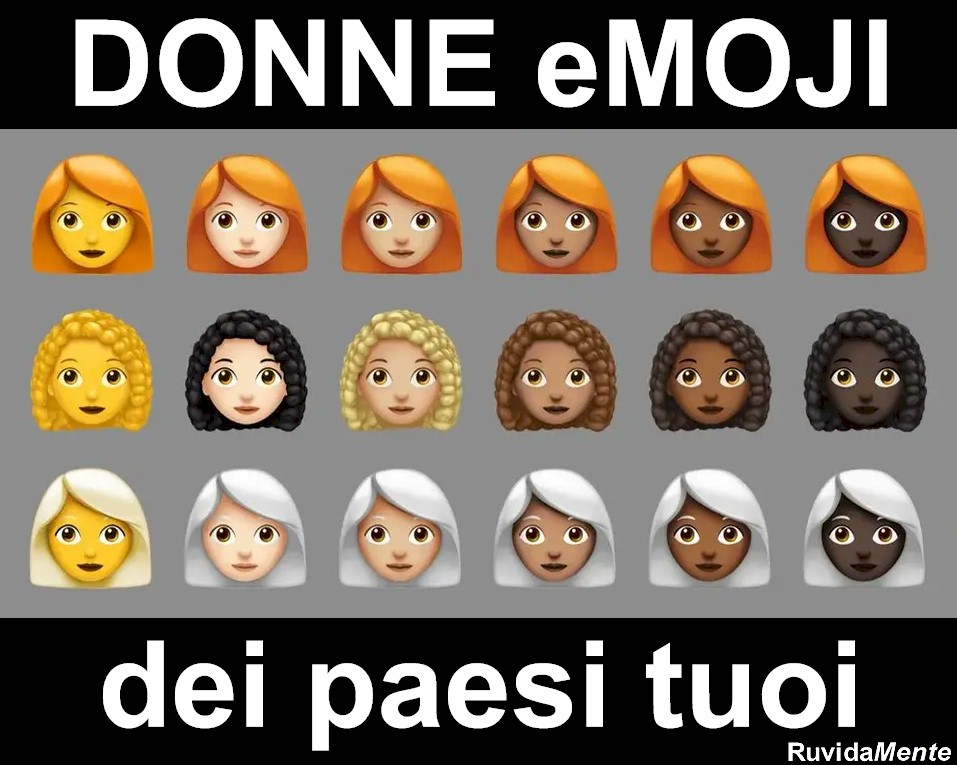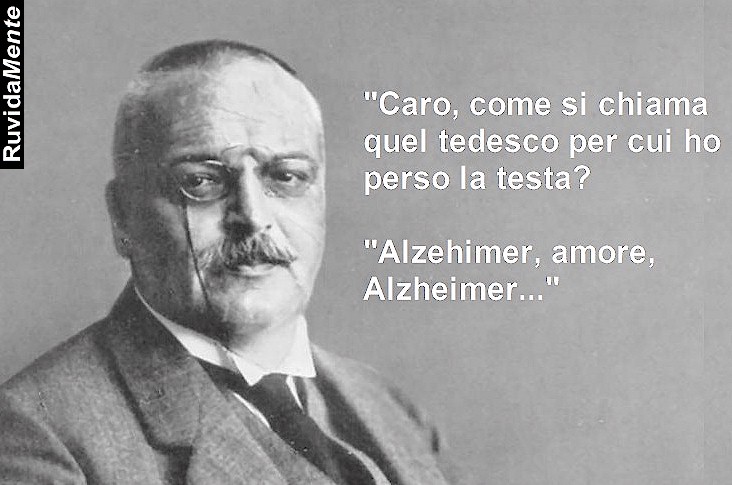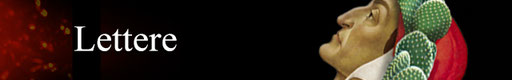

Pancia all'aria. Gambe divaricate sul terreno. In alto il cielo solcato da poche nubi, informi, incolori.
Una posizione pigra per chi si sente chiamato a fare un bilancio della propria vita.
Una vita coerente, senza nei, senza colpe. Forse una vita grigia per gli altri, ma piena di emozioni, di tensioni, di gioie. Una vita che non conosce momenti brillanti, tranne questo che ora attraversa veloce un tratto di cielo.
Gli occhi di mia madre, una madre già vecchia prima che io nascessi, non hanno mai brillato. Né di gioia, né per la presenza di una lacrima. Di mio padre non ho conosciuto la luce di un sorriso.
E non ho mai impugnato la lama che si è conficcata sfavillante nel ventre dell'uomo che ora si vuole io abbia ucciso.
Solo questo baffo di luce sfavilla scendendo dal cielo, occupandone una proporzione sempre più grande.
È vero, ho incrociato per strada, di notte, quell'uomo che recava alla mano un diamante enorme, accecante, sproporzionato. Non dice il falso chi testimonia che restai fulminato, guardandolo a lungo. Ma mi sono ripreso e mi sono allontanato veloce con gli occhi offesi da tutta quella ricchezza concentrata in un solo dito.
Offesi come ora da questa fetta di luce che scende dal cielo a velocità impressionante.
E nel grigio cupo del tribunale ricordo soltanto la fessura sottile degli occhi di brace di una vecchia sdentata che leva il dito verso di me gridando "È lui, è lui".
La mano tesa attraversa l'aula, s'infuoca e mi raggiunge, si allarga, mi afferra il collo e mi penetra. Non vedo più luce, il cielo è quello di sempre, ma quel fuoco, quella luce, li sento penetrare nel collo.
Che idea, volermi ghigliottinare a pancia all'aria, con gli occhi rivolti alla mia sentenza.
 RuvidaMente
RuvidaMente