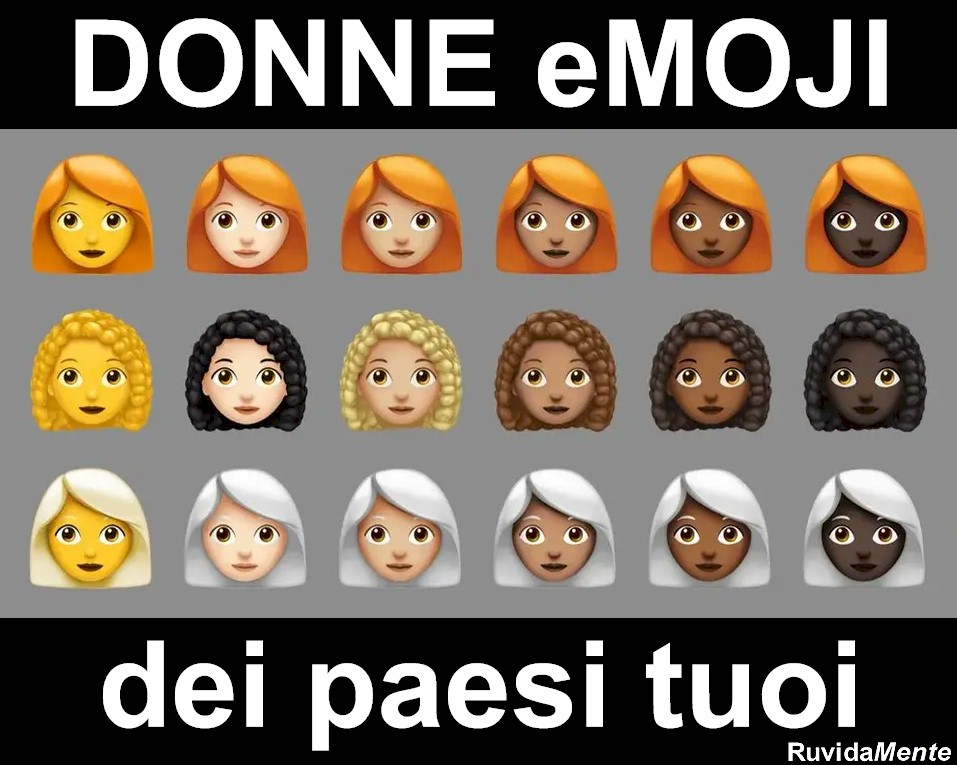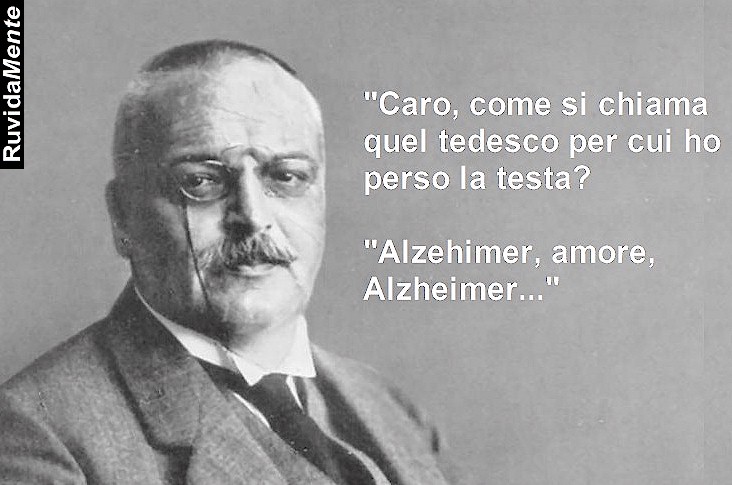In tutto il mondo è diffusa la convinzione che la pasta sia nata in Cina e che sia stata portata in Italia da Marco Polo. Eppure, basterebbe leggere le parole scritte nel 1298 ne "Il Milione", il libro che racchiude la relazione dei suoi viaggi in Estremo Oriente, per avere la conferma del contrario, e cioè che in quel tempo, in Italia, la pasta era un cibo quotidiano.
Marco Polo, infatti, scrive che in Cina aveva visto ed aveva egli stesso mangiato "lasagne simili a quelle che noi facciamo con farina di frumento”.
Ma, allora, chi ha inventato la pasta?Analizzando quasi tutti i fenomeni umani, siamo sempre alla ricerca di un inventore, un giorno, un mese ed un anno in cui qualcosa nasce. Però, quando parliamo di cibo, è praticamente impossibile trovare un inventore ed una data precisa. Soprattutto quando parliamo di cibi che oggi costituiscono la base alimentare di interi popoli.

Se c'è un inventore, quello è la fame, la carestia, la disperazione, la paura per il futuro. E questo è ancora più vero quando parliamo di pasta.
Per sintetizzare, possiamo dire che la pasta è stata inventata - e non poteva essere inventata - altro che da una popolazione che viveva in una grande città, centro di potere politico e militare, nel cuore di un'area in cui il grano era il primo ingrediente base dell'alimentazione.
In tutti i paesi dell'area mediterranea uno dei pilastri dell'alimentazione era costituito dai cereali e tre essi, in primo luogo dal grano.
La diffusione di questi cereali, oltre alle proprietà nutritive, era dovuta al fatto che, rispetto a tutti gli altri prodotti dell’agricoltura, erano molto più facilmente conservabili.
Per essere consumati, essi venivano macinati e la farina così ricavata veniva trattata in due diversi modi: cotta in un liquido che poteva essere acqua, brodo o latte (e di qui deriva la nostra odierna polenta), oppure impastata con acqua, e poi cotta su pietre roventi o in forno, ricavando pane e focacce.

Questi due modi ci consumare i cereali sono comuni a tutti i popoli del Mediterraneo e non cambiano di molto per alcuni millenni.
Ma ad un certo punto succede che proprio al centro del Mediterraneo, a partire dal terzo secolo a.C., esplode la potenza di Roma che anno dopo anno si espande fino ai confini del mondo allora conosciuto.
UN MILIONE E MEZZO DI PERSONE DA SFAMARE
Insieme al suo potere politico e militare, Roma vede espandere le sue dimensioni di città: nel 264 a.C. i suoi abitanti sono 264.000, nel 130 a.C. sono 313.000, nel 55 a.C. sono già un milione e cento anni dopo, durante l'impero di Augusto, diventano 1.500.000.
Cercate di immaginare come fosse complicato, 2.000 anni fa, gestire una città di 1.500.000 abitanti, visto che questo è un problema gigantesco anche ai giorni nostri.
Il primo, drammatico problema da risolvere era quello di garantire ai suoi abitanti sufficienti risorse alimentari. Il territorio circostante, infatti, non poteva in nessun modo produrre a sufficienza cibi per tutta la popolazione. E quel poco che veniva prodotto non aveva mercato, perché, grazie all'espansione politica e militare dell'Impero romano, le merci che arrivavano dai paesi conquistati avevano un prezzo molto più basso di quelle prodotte in loco.
Per risolvere questo problema, era stato messo in piedi un sistema di approvvigionamenti garantito, prima dalle regioni italiane (nel 70 a.C. la Sicilia produceva oltre 250 milioni di kg di grano), poi, dopo la loro conquista, dalle terre del Nord Africa.
Ai tempi di Augusto, per l'alimentazione di residenti di Roma si importavano mediamente dall'Egitto 135 milioni di Kg di grano, 175 milioni dal Nord Africa, 40 milioni dalla Sicilia, e poi quantitativi minori dalla Sardegna, dalla Siria e dalle Spagna, per un totale almeno di 350 milioni di Kg.

E per questi approvvigionamenti veniva impiegata stabilmente una flotta di 300 navi.
Ma, nonostante la disponibilità di questi mercati e l'organizzazione dei trasporti, capitava spesso che il grano venisse a mancare. Questo era determinato in primo luogo dalle frequenti carestie, poi dalla perdita delle navi durante il tragitto verso Roma. Ma il problema più grave era quello creato dalla conservazione di così grandi quantità di grano. Noi possiamo immaginare quali potessero essere le condizioni igieniche dei magazzini di allora, in tempi in cui non esistevano prodotti chimici o altre tecniche per difendere le merci dagli animali, dagli insetti e dai parassiti. Giusto per farci un’idea dell’entità del problema possiamo ricordare che nel 62 a.C. Nerone fu obbligato a far gettare nel Tevere tutti i cereali ammassati nei granai di Roma perché erano talmente infestati da parassiti che era impossibile utilizzarli per l’alimentazione.
La maggior parte di questo grano, ogni mese veniva distribuito gratuitamente, o a prezzo ridotto, alle fasce più povere della popolazione che per prima cosa si poneva il problema di eliminare insetti e parassiti. Esistevano due tecniche: la prima consisteva nell'abbrustolire i cereali, la seconda nel macinarli immediatamente.

Nel primo caso era il calore a fermare la proliferazione dei parassiti, nel secondo l'azione meccanica della macinatura.
Con i cereali abbrustoliti, si ricavavano poi delle farine con le quali si cucinava una specie di polenta. Con la farina, invece, preparavano pane e focacce. Il problema della farina, però, era che l'effetto di neutralizzazione di insetti e parassiti era solo momentaneo, perché oltre all'attacco di altri parassiti, sempre in agguato, si aggiungeva il rischio di deperimento dovuto all'umidità ed alla creazione di muffe.
Per ovviare a questo nuovo rischio esistevano due tecniche; la prima consisteva nel ricuocere nel forno il pane e le focacce, facendone un "biscotto", un prodotto di facile e buona conservazione. La seconda nell'impastare a lungo la farina con acqua, stenderla in fogli sottili e lasciarla essiccare. Il prodotto così ricavato, la prima pasta della storia, poteva essere conservato a lungo (anche un anno) e veniva consumato unendolo a zuppe di verdura, le famose "pultes".
Ecco quindi che le origini della pasta ci appaiono sotto una luce meno straordinaria e nobile di quella che vorremmo: si tratta di un prodotto povero, umile, inventato per preservare il prodotto base dell'alimentazione da un facile deperimento, e per garantirsi una riserva di cibo nell'eventualità che potesse saltare la distribuzione successiva di grano, a causa di una carestia, di una burrasca che ha impedito alle navi di raggiugere il porto di Roma, di una infestazione più grave delle altre nei depositi di grano.
La pasta, quindi è nata di fatto nella Roma Imperiale e non poteva nascere che in un luogo in cui, contemporaneamente, si verificassero le seguenti tre condizioni:
1
Una città di oltre un milione di abitanti che dipendeva da approvvigionamenti esterni, senza alcuna integrazione con l'agricoltura del territorio circostante
2
Il susseguirsi periodico di carestie che tenevano vivo nella gente lo spettro della fame
3
La difficoltà di conservare oltre un certo periodo i cereali, a causa della loro deperibilità, fenomeno che mentre era grave a livello di approvvigionamento collettivo, diventava drammatico a livello di singole famiglie per le quali, venendo a mancare le distribuzioni mensili di grano, non sapevano dove andarsi a procurare altro cibo.
Proprio grazie a questa misera origine della pasta dobbiamo il fatto che nella letteratura del tempo se ne parli molto poco.
Non se ne parla perché fino all’Ottocento, quando si è scritto di gastronomia lo si è fatto prevalentemente parlando dei potenti e dei ricchi, che, certamente, anche nella Roma Imperiale non si cibavano di pasta. Oppure esaltando (come ancora oggi) il sogno della vita agreste in cui i prodotti rustici e semplici sono i protagonisti della tavola di tutti i giorni.
Ma la pasta non ha alcuna relazione con la vita dei contadini, è un prodotto per sopravvivere in una grande città e
questo non è un argomento accattivante per un poeta.

A meno che non si tratti di un poeta controcorrente come Orazio, cui piaceva ostentare atteggiamenti in contrasto con la vita condotta dai potenti in mezzo ai quali viveva.
Nella sesta Satira del primo Libro, a dimostrazione di una vita sana e serena scrive "...quindi (la sera) ritorno a casa ad una scodella di porri ceci e lagane".
Ebbene, quelle "lagane", nome ancora oggi utilizzato in molte regioni meridionali, non sono altro che le nostre lasagne. E dopo Orazio, ne parlerà anche Apicio nel suo "De re Coquinaria", indicandole come ingrediente di molti piatti, non curandosi mai di spiegare come debbono essere fatte, e questo dimostra quanto dovessero essere comuni in quel tempo tra i Romani, visto che per ogni altro elemento viene sempre fornita una accurata spiegazione.
Se si analizzano bene i due testi, però, scopriremo che c'è una differenza tra le lasagne di Orazio e quelle di Apicio.
Le prime sono un cibo povero, buttato in pentola per preparare un cibo frugale, semplice. Le seconde sono l'ingrediente di un piatto raffinato, elaborato, che richiede una lunga preparazione e la mano abile di un cuoco. Le prime sono lasagne di pasta secca, le seconde di pasta fresca.

E nei secoli successivi, se nella letteratura e nelle testimonianze storiche avremo testimonianza di "pasta", si tratterà sempre di pasta fresca, preparata nelle cucine dei re e dei potenti, arricchita nell'impasto con uova, ridotta a strisce, a quadri, arrotolata e farcita con impasti preziosi di carni, pesci e verdure: agnolotti, tortellini, ravioli.
E che la pasta fresca fosse cibo dei ricchi e dei potenti prima ancora che a Roma si verificassero le condizioni per l'invenzione della pasta secca, è testimoniato dalla più antica testimonianza della pasta in Italia, nella tomba dei rilievi di Cerveteri (la tomba di un uomo potente, quindi) in cu sono riprodotti in stucco, sui due pilastri centrali, gli strumenti per lavorare la pasta a mano: la tavola spianatoia, il mattarello, il sacchetto per spolverare la farina sulla tavola, il mestolino per l'acqua, il coltello per tagliare la sfoglia e la rotella per dare un bodo ondulato alla pasta.

Per quanto riguarda la pasta secca, le testimonianze sono scarse o nulle per circa un millennio, e si tratta sempre di lasagne o formati simili. Solo dopo l'anno 1000 si hanno le prime testimonianze di altri formati di pasta, in particolare i "Vermicelli" (tria) che, di sicura provenienza araba, venivano prodotti in Sicilia e che venivano esportati nel resto d'Italia.
Ed i famosi "maccheroni", almeno agli inizi non sono un ben definito formato: con quella parola si identificavano forme diverse di pasta, tipo gnocchi o palline schiacciate con le dita o con appositi strumenti, tutte realizzate con la stessa tecnica, quella di schiacciare.
LA PASTA PRENDE FORMA
L'invenzione di nuovi formati si fa più vivace dopo il 1300, ma siamo sempre in un ambito ristretto, confinato ad usanze locali e non il segnale di una evoluzione verso una produzione industriale: la pasta è ancora un prodotto alimentare di riserva, una garanzia per il futuro, consumata periodicamente non come abitudine alimentare primaria, ma per la necessità di rinnovare le scorte.
Contrariamente a quanto ognuno immaginerebbe, fino al XVIII secolo, a Napoli la pasta non è un cibo primario. Anzi, fino a quell'epoca, i Napoletani venivano chiamati "mangiafoglie".

Ma, con l'avvento del dominio spagnolo, caratterizzato da una dissennata gestione dell'amministrazione pubblica, le problematiche di carenza delle scorte alimentari si fanno sempre più frequenti e più gravi, e questo diventa lo stimolo per un utilizzo massiccio della pasta secca come scorta alimentare, pasta secca che diventa sempre più affidabile da questo punto di vista grazie all'impiego, nella sua produzione di due nuove "macchine", la gramola ed il torchio, che permettono di ottenere, per la prima volta, una pasta simile, per struttura e risultato finale, a quella che mangiamo noi oggi.

Il perdurare di questo stato di emergenza per tutta la dominazione spagnola fece sì che i Napoletani, nel corso di due secoli si trasformassero da "Mangiafoglia" in "Mangiamaccheroni" e con questo nome fossero conosciuti ovunque a partire dal XVIII secolo.
Ancora una volta, vediamo che la pasta diventa l'emblema di un popolo non per meriti gastronomici, perché era un cibo che dava piacere e che si era orgogliosi di mangiare, ma solamente per combattere la fame e la povertà. Negli stessi anni, infatti, e fino alle soglie del XIX secolo, nelle case dei nobili e dei potenti trionfava la cucina raffinata, ricca di paste fresche e ripiene ed il loro uso, lentamente, si diffondeva tra le classi più agiate, testimoniato dall'aprirsi sempre più frequente, soprattutto nelle città del nord Italia, di botteghe di pastai, artigiani specializzati che preparavano e vendevano sempre e solo pasta fresca.
Dopo questa veloce passeggiata nei secoli, possiamo tranquillamente affermare che la pasta secca è un'invenzione culinaria unicamente e tipicamente italiana e la cui preparazione e consumo si diffuse in tutta Italia per una combinazione di numerosi eventi e condizioni storico-sociali.

Allo stesso tempo, la pasta sembra aspettare da secoli il suo tempo, in attesa di un catalizzatore che desse lo slancio necessario per il raggiungimento del suo pieno potenziale: l'elevazione al rango di alimento primario capace non solo di soddisfare la fame ma anche di rallegrare il palato.
Fino al XVIII secolo il consumo di pasta era essenzialmente riservato ai poveri, che la adottarono principalmente per la sua lunga capacità di conservazione e per il suo eccezionale valore nutritivo, non perché la trovassero particolarmente appetitosa. Di solito veniva bollita e consumata da sola o insaporita, al massimo, con un po' di formaggio grattugiato.

Come piatto, presentava poca o nessuna raffinatezza e non si facevano storie nel presentarlo. I vermicelli venivano presi dal piatto con le mani e portati alla bocca, senza tante cerimonie.
IL FELICE MATRIMONIO TRA PASTA E POMODORO
Solo quando è stata abbinata al pomodoro la pasta è diventata un vero e proprio "piatto" e un elemento base della dieta, che ha ispirato i cuochi a ideare ricette da pubblicare e diffondere.
Parlando di pasta, e della pasta che noi mangiamo oggi, è importante ripercorrere anche la storia del pomodoro, fino al loro incontro.
Il pomodoro arrivò in Italia, almeno ufficialmente, nel XVII secolo. Fu introdotto nel paese dagli spagnoli, ma allo stesso tempo non introdussero alcuna preparazione culinaria in cui il frutto fosse impiegato.

A quanto pare ci volle più di un secolo e l'ingegno dei meridionali, stimolati dalla carestia cronica, per far convivere pomodoro e pasta. Chi fece quel fatidico passo è impossibile dirlo ma pare che alcuni carrettieri del trapanese, presto emulati dagli abitanti rurali della Sicilia occidentale, iniziarono la pratica di aggiungere all'acqua una cospicua quantità di pomodoro tagliato a fette in cui venivano bolliti maccheroni o vermicelli.
In Campania, patria adottiva della “pummarola” o passata di pomodoro, la coltivazione del pomodoro su vasta scala tardò ad avviarsi, nonostante la pianta fosse coltivata per la prima volta nella regione già nel 1596.
Quel che è certo è che un piatto di maccheroni conditi con un po' di formaggio si vendeva alla fine del '700 a due centesimi nelle osterie di Napoli. Al Nord, invece, il pomodoro veniva coltivato come pianta ornamentale.
Il botanico senese Pietro Andrea Mattioli (1500-1570) fu il primo in Italia a chiamare il pomodoro con il nome che da allora ha conservato in italiano, pomo d'oro o mela d'oro. Mattioli si riferiva a uno dei colori che il pomodoro assume durante la sua maturazione. Mentre gli italiani chiamano il frutto pomodoro (il plurale è pomodori), francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi continuano a usare termini derivati direttamente dal nome che gli diedero gli indiani Nahuatl del Messico, “tomatl”.

Parlando della melanzana, il Mattioli riferisce nel 1544 che "un'altra specie, nota come Pomi d'Oro, è stata portata in Italia ai nostri giorni. I frutti sono di forma compressa, come mele rosa, e crescono a grappoli. Dapprima sono di colore verde e da alcune piante sono rosse come il sangue quando maturano, mentre altre sono del colore dell'oro. Entrambi vengono mangiati allo stesso modo ". In quel “modo” vuol dire tagliata a fette, infarinata e fritta. Nel giro di tre secoli il pomodoro era stato accettato ovunque in Italia.
Ne Il Cuoco Galante, uno dei primi libri di cucina italiani completi, il napoletano Vincenzo Corrado (1734-1836), monaco celestiniano, scriveva che: "dal pomodoro si possono fare varie pietanze gustose.

La salsa preparata con esso può essere usata per insaporire carne, pesce, uova, pasta e verdure: un buon cuoco può facilmente creare deliziosi bocconcini e una salsa universale [poiché può essere utilizzata in molti modi]. Il pomodoro non solo delizia il palato con il suo sapore ma giova anche all'organismo, poiché il suo succo acido aiuta la digestione, soprattutto durante la stagione estiva quando lo stomaco delle persone è flaccido e in preda alla nausea a causa del caldo opprimente. Questi pomodori estivi sono rotondi e color zafferano.
Hanno una pelle che va tolta facendole ruotare sopra le braci e tuffandole poi in acqua bollente. È possibile togliere i semi, per assicurare preparazioni più delicate e soddisfacenti, aprendo un foro nel punto in cui il gambo si unisce al pomodoro o tagliando i pomodori a metà."
In precedenza, però, la letteratura sul pomodoro era piuttosto scarsa, e questa è la prova più convincente della scarsa diffusione della pianta.
Una delle prime pubblicazioni dedicate alla coltivazione del pomodoro fu I Pomi d'Oro di Giovanni Francesco Angelita Roco, uscito a Recanati nelle Marche nel 1607.
Tuttavia, solo un secolo dopo, nel 1705, Francesco Gaudentio, coadiutore laico per le vettovaglie di una comunità di Gesuiti a Roma, fornì la prima ricetta italiana di pomodori cotti nel suo Panunto Toscano, il cui manoscritto è conservato nella Biblioteca Comunale di Arezzo. La ricetta: "Questi frutti sono molto simili alle mele. Si coltivano negli orti e si cucinano nel seguente modo: si raccolgono i pomodori, si tagliano a pezzi e si mettono i pezzi in padella con olio, sale, aglio tritato e menta selvatica. Stufarli, mescolando spesso il composto. Il piatto sarà ancora più buono se si aggiungerà un po' di tenere molignane [melanzane] o cucuzze bianche [zucche]”.
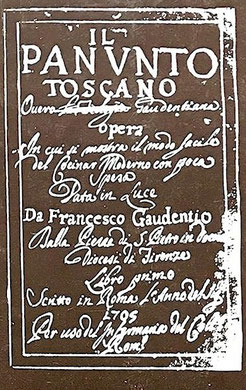
Solo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo il pomodoro venne "ufficialmente" promosso da gourmet e grandi
chef, a partire proprio da Corrado, un monaco celestiniano che, dal suo osservatorio privilegiato a Napoli, raccontò di aver assaggiato la sua prima "coscia di capretto spalmata di concentrato di
pomodoro e lardellata di lardo e spighe di rosmarino e arrostita in forno con burro ed erbe aromatiche".
Nella terza edizione de Il Cuoco Galante, pubblicata nel 1773, l'attento buongustaio elencò le seguenti ricette a base di pomodori: (dal Trattato Primo - Cibo pitagorico) ripieno di vitello,
condito con salpicanti (saupiquet, una salsa pungente), farcito e cotto in burro, ripieni di verdure, ripieni di riso, alla Corradina, ripieni di pesce, cotti in salsa di
tartufo, alla napolitana, nelle crocchette, nelle frittelle e nel budino.

Due anni dopo, Francesco Leonardi, già cuoco di Caterina II la Grande, imperatrice di tutte le Russie, pubblica il suo Apicio Moderno. Nella seconda edizione di quell'opera, apparsa nel 1797, si trova la prima ricetta del culì (o coulis), una salsa di pomodoro alla francese allora molto di moda. Tuttavia, non si fa menzione del suo possibile utilizzo con la pasta.
Dovevano passare altri 40 anni prima che comparisse la prima ricetta dei vermicelli col pomodoro. Tuttavia, è sempre possibile che molte massaie abbinassero già da tempo pomodoro e pasta, anche se all'epoca tale pratica non era molto diffusa.
Gli affascinanti acquerelli napoletani del primo Ottocento raffigurano sempre maccaronari o mangiatori di maccheroni che si rimpinzano, con le mani, di pasta in bianco. Vuol dire che veniva insaporita solo con formaggio grattugiato - o incaciata, secondo l'espressione dell'epoca.

I primi vermicelli storici “co le pommodoro” furono descritti nel 1839 da Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino (1787-1860), in "Cucina Casareccia in Dialetto Napoletano", appendice de La Cucina Teorico-Pratica.
Nella Regola 10 del capitolo dedicato ai sughi, Cavalcanti aggiunge:

“[Il pomodoro] va bene se vuoi preparare maccheroni o qualsiasi altro tipo di pasta piccola. I pesci, che sono buoni con un po' di burro.
Fate questo ottimo sugo per insaporire i vermicelli ma, se lo ungete con l'olio, sarà ancora più buono e più saporito."
È solo nella prima metà dell'Ottocento che il consumo di pasta secca si diffonde rapidamente nella società, diventa di moda e servirla diventa un segno di distinzione.
BENEDETTA SIA LA FORCHETTA!
Tuttavia l'aggiunta del sugo rendeva la pasta un piatto disordinato da mangiare con le mani e uno strumento tanto curioso quanto trascurato fino a quel momento, iniziò presto a comparire sulle tavole della borghesia: la forchetta.
Quell'attrezzo esisteva da diversi secoli in varie forme e aveva ricoperto varie funzioni sulle tavole delle famiglie raffinate e snob di tutta Europa.

Tuttavia, il suo utilizzo come utensile standard non era stato stabilito. La forchetta veniva messa sulle tavole di un ristretto numero di nobili per fare colpo sugli ospiti piuttosto che aiutarli a mangiare. La diffusione della pratica di mangiare la pasta condita con la salsa di pomodoro ha portato all'adozione della forchetta come utensile quotidiano. I numerosi modelli precedentemente conosciuti furono abbandonati. La forma e le proporzioni della forchetta vennero modificate e, nel giro di pochi anni, apparve un unico formato. Il nuovo attrezzo standard aveva quattro rebbi ricurvi, la cui lunghezza non superava il doppio della loro larghezza combinata.
Qualsiasi maitre d'albergo oggi potrebbe fornire un lungo commento sulle precise forme e funzioni delle forchette, comprese quelle utilizzate per mangiare pesce, carne, piatti "salsati", dolci e frutta.
E senza dubbio avrebbe espresso disapprovazione per qualsiasi uso improprio dell'utensile. Sta di fatto, però, che, ormai da due secoli, nelle case private e nella maggior parte dei ristoranti di tutto il mondo è consuetudine utilizzare per quasi tutti gli usi solo la forchetta pensata per la pasta, con i suoi quattro rebbi ricurvi.

La pasta condita con olio e pomodoro costituisce solo un inizio, non un traguardo gastronomico, perché quel piatto essenziale apriva un nuovo mondo di sapori e profumi.


Mentre l'inventiva si è arenata per secoli sui vermicelli bolliti con, magari, l'aggiunta di un po' di formaggio per renderli più saporiti, la fantasia delle massaie, prima, e poi di cuochi e buongustai ha prodotto nel giro di pochi anni una miriade di preparazioni in cui al pomodoro e al suo sugo si sono abbinati i migliori prodotti della tradizione italiana, come la mozzarella, la provola, il parmigiano, il prosciutto, il guanciale e un'infinita carrellata di formaggi, pesci, carni, conserve e prelibatezze. La pasta e tutti questi prodotti della tradizione sono stati chiamati in causa in una vera e propria orgia di innovazione, in cui la cucina italiana è stata completamente rinnovata.
L'Ottocento, il secolo dei grandi cambiamenti politici in Italia, dalla dominazione straniera all'unità nazionale, il secolo del Risorgimento, di Garibaldi e di Cavour, è anche il tempo dell'evoluzione finale della pasta, il passaggio dalla miseria alla nobiltà, da cibo di sopravvivenza a prelibatezza.
E nello stesso momento in cui esplode la creatività degli chef, emerge la forza inventiva dei pastifici. In questo secolo, piccoli e grandi pastifici avviano una metodica ricerca di nuovi formati capaci, allo stesso tempo, di catturare l'attenzione dei consumatori, e di assicurare loro nuovi e sconosciuti piaceri gastronomici.
La storia della pasta negli ultimi due secoli è un mix di fantasia, tecnologia e marketing. Una storia lunga e complessa che racconteremo presto…
LEGGI ANCHE:
 RuvidaMente
RuvidaMente